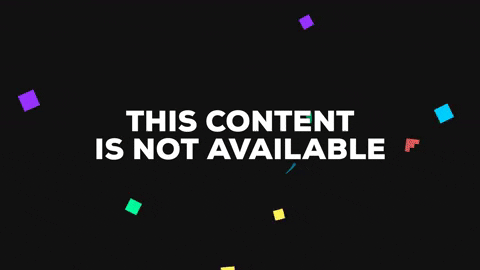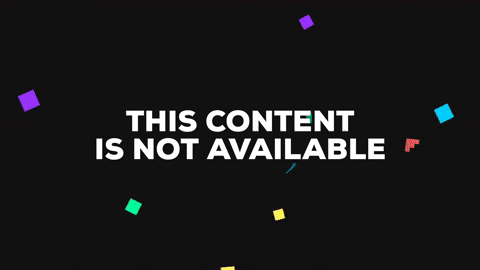Difficile credere che qualcuno, almeno quelli attenti alla “scena”, non abbia sentito parlare di Giorgio Poi. Il suo Fa niente lo ha proiettato nel circuito di “quelli da tenere d’occhio”, protetto dall’egida di Bomba Dischi, che continua a imporsi come una delle più lungimiranti etichette indipendenti. Singoli come “Niente di strano” o “Tubature” sono già nelle playlist dei migliori brani dell’anno e i millennials (ma non solo) invadono i concerti facendo registrare il tutto esaurito, come nella data romana al (riaperto) Quirinetta.
Giorgio Poi può esser uscito fuori come un fulmine a ciel sereno nel panorama italiano, ma Giorgio Poti è musicista attivo da anni, soprattutto fuori dai confini nazionali, prima con i Vadoinmessico e poi con i Cairobi.
A proposito dei Cairobi, qual è lo status attuale della band? Ufficialmente, sciolti, in pausa a tempo indeterminato o solamente “a progetto”?
Diciamo che non stiamo facendo concerti per il momento, perché io sono impegnato qui in Italia. Però in teoria si va avanti, il progetto per ora rimane aperto.
Se non ti fosse venuta voglia di scrivere in italiano, i brani di Fa Niente avrebbero potuto essere dei Cairobi?
Sì, forse sì. Io ho sempre scritto le canzoni da solo, nello stesso modo. La differenza è che qui ho registrato e finalizzato da solo tutte le parti, quando invece mi sarei consultato con gli altri.
Quindi in fase di composizione non hai fatto scelte volutamente diverse per il mercato italiano.
No, non particolarmente. L’unica differenza è stata che ho scritto per tre invece che per quattro. Ho lavorato sul suono in modo che fosse riproducibile con chitarra, basso e batteria, eliminando i sintetizzatori.
Nello scrivere un pezzo, molto spesso un compositore è influenzato dal suo “ruolo”, o comunque dallo strumento che suona prevalentemente. Tu però nel disco li hai suonati tutti. Qual è stato il tuo approccio?
Io solitamente parto dalla chitarra. Con la chitarra cerco una canzone, una melodia che mi possa interessare. Per alcuni pezzi sono partito invece dalla batteria, perché volevo fare una canzone che avesse proprio quel particolare beat. Dopodiché semplicemente mi metto a improvvisare e spero che esca qualche cosa. È un processo abbastanza spontaneo, non sto pensando a che tipo di cosa voglia fare.
Quindi la tua priorità è avere una melodia forte, trovare un hook.
Sì, anche se magari non è la prima cosa che viene fuori, e posso trovarlo strada facendo. Per me la cosa principale è che ci sia la canzone, che il pezzo funzioni, con la melodia della voce e gli accordi che ci metto sotto. Se non c’è quello non c’è proprio il pezzo! Poi posso avere anche l’arrangiamento più fico del mondo e che mi piace un sacco, ma se non riesco a trovarci dentro la canzone, finché non sento che c’è tutto, il pezzo non esiste. Potrei buttarlo via all’ultimo secondo perché non riesco a chiudere l’ultima cosa.
Una volta i cantautori italiani proponevano pochissimi brani strumentali, mentre negli ultimi anni è quasi diventata la prassi. Qual è il tuo rapporto con gli strumentali del tuo album? Necessità di fare un po’ di minutaggio? Non voler buttare via una buona intuizione musicale isolata? O magari il desiderio di proporre qualcosa di differente?
Anche nei lavori che ho fatto in passato ho sempre messo una o due tracce strumentali, per il semplice motivo che mi piace spezzare l’andamento del disco. Mi piace ascoltare un album e avere un momento di interruzione, un momento più raccolto in cui non c’è la voce, ci sono meno strumenti. Quindi mi piace metterlo anche in un disco che faccio.

Chi scrive di musica finisce sempre a fare il gioco delle somiglianze, e anche tu sei stato accostato a molti cantautori (a volte per motivi inspiegabili). Di contro, gli artisti rispondono citando i propri miti musicali, e spesso poi non sono quelli che emergono dalle tracce, come quando trovi il chitarrista metal che dice di amare Bob Dylan. Proviamo a fare un gioco: se tu dovessi scrivere del tuo album, a parte “Giorgio Poi”, chi diresti di sentirci dentro?
È molto difficile. Onestamente non so cosa ne scriverei, perché è difficile guardare al mio disco con un certo distacco.
Un musicista fa il suo piccolissimo percorso personale, che è fatto di dettagli. Ovvero prende dei dettagli da qualche cosa che ha ascoltato nel corso della propria vita e li rielabora. Quindi ritmicamente ci sono elementi che vengono da un determinato posto, e quelli melodici magari da un altro. Alcune volte me ne accorgo, altre volte è inconscio.
Molto spesso l’influenza non si sente, però c’è lo stesso. Magari il chitarrista metal, quando fa un certo tipo di fraseggio, è consapevole che quelle tre note che ha messo in fila gli vengano da Bob Dylan, però è irriconoscibile per chiunque altro perché è completamente in un altro stile, con un altro suono e con un altro strumento. Io sono molto influenzato da alcuni dischi di Sun Ra, ma poi ascoltando il mio disco dici che non c’entra niente, perché è un altro stile.
Melodicamente ad esempio ci sono molte influenze di Piero Ciampi, che non vengono colte immediatamente perché sono frutto di rielaborazioni che ho fatto. Magari non è così ovvio per gli altri, però io me ne rendo conto, sono consapevole che quella cosa, quel passaggio melodico venga da lì.
Una discussione che mi è capitato di affrontare più di una volta è quella se i Beatles facessero pop o rock. Genericamente alla fine ci si accorda per “pop-rock”, perché la svalutazione del termine porta spesso a identificare come “pop” un certo tipo di musica commerciale. Tu che genere pensi di fare?
Io ritengo di fare pop, nel senso che faccio delle canzoni che hanno più o meno una strofa e un ritornello, e durano attorno ai 4 minuti. Non mi avventuro in definizioni più dettagliate di questa, principalmente perché non mi interessa. Quando scrivo non mi chiedo che genere faccio, che tipo di pezzo stia scrivendo. Cerco di trovare una cosa che mi piaccia, che già è abbastanza complicato. Poi è come si usa questa struttura che aiuta a definire nello specifico un genere piuttosto che un altro.
A proposito di Beatles, quando si scrive il testo di una canzone, si va da chi prova a mettere in musica i propri poemi ai cantautori come Paul McCartney, che magari scelgono le parole in base al suono. Tu dove ti poni in questa scala ipotetica?
Sicuramente sto molto attento al suono delle parole che scelgo, perché voglio che suonino in un certo modo.
A volte nello scrivere la melodia improvviso delle parole che non hanno senso, ma che hanno un certo suono che mi piace. Poi provo a trovare una storia all’interno di quei suoni, cercando altre parole che lo mantengano. Alla fine il significato viene fuori un po’ da sé.
I miei sono testi abbastanza personali e privati. La ricerca avviene soprattutto all’interno di me: cerco di esprimere quello che penso della mia vita
Ho notato che in tutte le canzoni dell’album i verbi sono alla seconda persona singolare, si parla sempre a un “tu”. Sono tutte istantanee della tua vita o più una sorta di “amore pensato”, ideale?
Mi piace rivolgermi a una persona quando scrivo un testo, come se stessi parlando con qualcuno. Forse mi aiuta a esprimermi.
Quasi una sorta di seduta psicologica a tu per tu, in cui si può parlare liberamente.
Esatto, mi sento più tranquillo, più libero.
Una di queste è “Le Foto Non me le Fai Mai”. In mente rimane il ritornello, e traspare questo senso di rimpianto, però a leggere il testo c’è l’invito opposto: quello a “sottrarre la vita all’archeologia”. È quasi un’altra “People Take Pictures of Each Other” dei Kinks.
È perché “le foto non me le fai mai” è una cosa che mi dice spesso la mia ragazza, e io mi ritrovo un po’ con questo senso di colpa, perché mi rendo conto che è vero, che non mi capita quasi mai di tirare fuori il telefono e fare una foto. Da un certo punto di vista ha ragione, ma dall’altro c’è il mio desiderio di vivere il momento senza doverlo interrompere con un gesto così meccanico.
Peraltro una cosa che non ho mai sentito dire è “Vuoi vedere questo video di 40 secondi che ho fatto un anno fa a un concerto?”
Guarda, non me la sento di dare un giudizio, ognuno fa come crede. Io non tiro fuori il telefono, soprattutto quando c’è la mia canzone preferita, quella che stavo aspettando e non vedevo l’ora di sentire. Anche perché non me la riuscirei a godere. Invece sto lì e me lo godo, tanto non avrà mai lo stesso sapore riguardarla sul telefono.
A proposito di pubblico, ormai sei a tre quarti del tuo tour. Che riscontro stai avendo?
Fin qui molto buono, sono contento. Le persone vengono ai concerti, curiose di vedere come il disco verrà poi trasformato dal vivo. È bello vedere le persone che cantano, molto appagante.
Con chi ti piacerebbe fare una collaborazione nella scena attuale indipendente? E di che tipo?
Mi piace molto L’Officina della Camomilla, ma non so in che modo potremmo collaborare. Mi piacerebbe sederci a parlare della loro musica.
Magari potrebbe essere l’occasione per scrivere a quattro mani.
Non ci ho mai provato, potrebbe essere interessante. Magari poi non ci riesco e mi blocco, mi vergogno.
In concerto proponi anche un brano inedito. Hai già qualcosa in mente per il tuo prossimo lavoro?
In realtà non ci ho ancora iniziato a pensare.
Sto scrivendo dei pezzi in maniera disordinata, semplicemente perché mi va di farlo, ma non c’è ancora un’idea o una forma. Mi piacerebbe tentare qualcosa di diverso rispetto a quello che ho fatto finora. Quanto diverso, staremo a vedere.
Luigi De Stefano